`I Miserabili`di Victor Hugo • I Dreamed a Dream
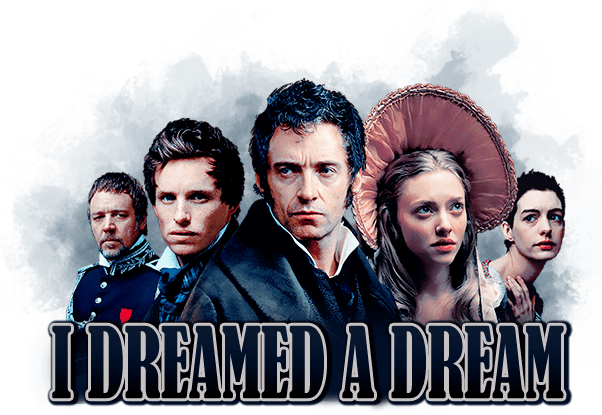
I Romanzi di Victor Hugo sono pietre miliari; come Virgili cartacei conducono il lettore al cospetto delle sentinelle del tempo, guardiani di un passato non troppo lontano, ancora luminoso e sfavillante sotto uno strato polveroso di Storia. I Romanzi di Victor Hugo sono in grado di trainare l’animo umano oltre i campi dell’etere celeste, oltre il confine ultimo delle lande stellate, rimanendo tuttavia fedeli alla voluttà della vita terrena e ai suoi più profondi e oscuri abissi.

I Romanzi di Victor Hugo nascono dal fango, dalla melma sotterranea, e da questa sono in grado di librarsi in volo in un cielo diverso, per cercare un riscatto, finalmente liberi dai miasmi e dagli immondi climi della civiltà umana; fendendo il velo dell’immensità imponderabile, si scrollano di dosso il fardello di tribolazioni che incombe sulla vita e, planando leggeri sull’indigenza, sulla sofferenza, sulla tristezza e sull’amore, sono in grado di descrivere questa alchimia di gioia e dolore con il linguaggio più puro e sublime, quello delle stelle e delle cose mute.
I Martiri ricevono consolazione e i Miserabili, finalmente, trovano un portavoce.
Chi per caso si dovesse trovare a Parigi dalla parte di Place des Vosges, può decidere di compiere un pellegrinaggio, più sentimentale che letterario, alla casa di Victor Hugo. Qui, in mezzo a orrendi mobili di dubbio gusto orientaleggiante, costruiti dallo stesso scrittore, sarà forse attratto da una piccola vetrinetta contenete svariati cimeli del tempo che fu. In mezzo a varie “reliquie” raccolte dallo stesso Hugo sul campo di battaglia di Waterloo, come pallottole, papaveri essiccati o ferri di cavallo, si potranno notare una tabaccheria di smalto con l’iscrizione “Les Misérables. V.H.” e sei penne d’oca un po’ malmesse; sec0ndo un cartellino, quelle furono lo strumento di cui Victor Hugo si servì per la redazione de ‘I Miserabili’.

Ovviamente, di penne d’oca ce ne saranno volute molte di più per completare un capolavoro di più di 1300 pagine, un’impresa così gigantesca la cui ideazione risalirebbe secondo alcuni addirittura al 1820, sebbene la stesura abbia impegnato lo scrittore per “soli” cinque anni, con in mezzo un’interruzione di dodici.
‘I Miserabili’ furono pubblicati per la prima volta il 3 aprile 1862, simultaneamente a Parigi e a Bruxelles. L’impatto che quest’opera ebbe sulla popolazione fu impressionante: alle quattro del pomeriggio, erano state vendute già 3500 copie della prima parte del romanzo, mentre una settimana dopo la prima tiratura era già esaurita. Il trionfo si materializzò come tale con più di centomila copie vendute nel novembre dello stesso anno. Il regime di Napoleone III, per quanto incline alla censura, difficilmente poteva intervenire per bloccare un’ondata di successo tale da diventare movimento d’opinione, per cui, prudentemente, il libro non fu vietato.
Al contrario di quanto si possa pensare, i lettori de ‘I Miserabili’ non appartenevano all’aristocrazia o ai circoli letterari borghesi, ma erano perlopiù operai delle fabbriche. Le cronache dell’epoca ricordano addirittura di come i “poveri” organizzassero delle collette per racimolare i 12 franchi necessari all’acquisto del volume che, dopo essere stato letto da tutti, veniva assegnato a un fortunato vincitore tirato a sorte.

Tra il 1862 e il 1863, il libro fu tradotto e distribuito anche in Germania, Italia, Spagna, Portogallo, Polonia, Paesi Bassi, Scandinavia e perfino in America Latina, diventando un caso che, anche agli occhi di oggi, esula dal semplice successo letterario. ‘I Miserabili’ è probabilmente il più importante romanzo francese mai stato scritto, tale per la ricchezza del suo contenuto, per i suoi indimenticabili personaggi, per il sapiente dosaggio di elementi narrativi con la realtà storica concreta come sfondo, ma, soprattutto, per il messaggio rivoluzionario che trasmette: un invito ad aprire gli occhi, a osservare senza paura il marcio che ci circonda, per poi cambiare, attuare una rivoluzione, rovesciare un ordine sociale profondamente sbagliato e rimettere in discussione i principi su cui esso è fondato.

Fra i mutevoli romanzi di Victor Hugo, ‘ I Miserabili’ è forse la sua opera più sobria e controllata; in questo monumentale monolite d’inchiostro, Victor Hugo abbandona gli accenti più tragici e grotteschi, lasciando all’intuizione letteraria ciò che prima veniva mostrato: la deformità di una realtà ingiusta non è più rappresentata dalla fisicità ributtante di un solitario protagonista, ma alberga nell’animo fumoso di Jean Valjean, repressa, ma ugualmente tangibile; allo stesso modo la Fatalità non viene più rappresentata come una dama oscura, come un’incisione nera di vetustà, una tanto sublime quanto nauseante presenza invocata dall’abisso della Corte dei Miracoli o dalle torri di Notre-Dame, ma aleggia come un’ombra sullo sfondo di ogni avvenimento, spietata, una foschia melanconica che avvolge tutti i protagonisti.
Il romanzo nasce sullo sfondo di una spiccata sensibilità di Victor Hugo nei confronti dei problemi sociali, a cominciare dal sistema penale della Francia e dalla miseria a cui erano condannati le fasce più deboli e umili della società, come quella degli operai, degli anziani o dei bambini illegittimi. Fin da giovanissimo, del resto, Victor Hugo non aveva mai indugiato nello schierarsi dalla parte dei sofferenti, dei deboli o dei condannati.

‘I Miserabili’ costituiscono l’espressione più agile e matura del genio di Hugo, pregni di una morale imprescindibile, che ha l’obiettivo di ricordare ad ognuno di noi quanto la “lettiga della civiltà” sulla quale siamo placidamente adagiati, in realtà “avanzi senza sussulti” solo grazie al sangue, al sudore e alle lacrime di molti; il pane quotidiano, la pace domestica, tutto ciò che rende lieta la nostra esistenza, è pagato profumatamente dalla Storia, dalla morte di uomini e animali, da un’infinità di ingiustizie che, troppo spesso, trasformano il nome di rivoluzionari in quello di despoti o criminali.
Scorrendo le pagine di questa tragica vicenda, il lettore si accascia sotto il peso funesto della civiltà e non può fare a meno di ristorare con le proprie lacrime gli umili condannati a portarlo. Vedere la Provvidenza, scossa da febbri letali, costringere Jean Valjean a piegarsi sotto la violenza degli eventi, condotto alla tragedia a causa di una colpa senza nome e senza volto, provoca in ognuno di noi collera e sdegno, lo stesso che potremmo provare al cospetto della crocifissione di un Dio. Eppure, benché questa trama sia dipinta con fosche tinte, questo grande Romanzo è anche pieno di luce e di amore.

Comporre il poema della coscienza umana, come scrive lo stesso Hugo, significherebbe fondere tutte le epopee in una epopea unica, definitiva e superiore. Eppure, per raggiungere questo obiettivo, basterebbe semplicemente osservare il riflesso del volto livido di un essere umano in certe ore e provare a intravedere i contorni di quell’anima, convulsa, quasi tarantolata, spasmodica nell’oscurità; sotto il lugubre silenzio esteriore si nasconderebbero lotte di giganti, draghi e idre in volo, un cupo infinito di visioni dei più oscuri gironi danteschi. Caos, chimere, sogni, tutti racchiusi in un antro al cui cospetto abbandoneremmo ogni speranza, come l’Alighieri sgomento davanti alla porta dell’Inferno. Attraverso questo abissale viaggio, forse, potremmo capire molto della storia dell’uomo; tuttavia, Hugo lascia gli storici “alle prese tra loro”, proclamandosi “testimonio a distanza”, un passante delle lande desolate, un contemplatore chino su un terreno impastato di sangue. Nessuno ha il diritto di tenere testa al Tempo e occorre quindi limitarsi a giudicare come membri del popolo, il più ingenuo fra i giudici.
Ma chi sono veramente i Miserabili? E perché sono chiamati tali?

In questa schiera infernale non vi è distinzione di classe, non vi è santità o signoria e non vi è indigenza o bestialità, non vi è bontà o cattiveria, solo umile e sublime dannazione.
Ogni Miserabile è fatalmente votato alla tragedia. Ogni Miserabile è solo, in colloquio con il proprio Dio, mentre intorno a lui vi sono unicamente spettri, l’oscura foschia del Fato, un’ombra crepuscolare che non si cura dell’uomo solitario, ma che lo rende cieco. Il Miserabile è il morente sublime, è il pregiudizio divino, l’uomo raggiunto al limite estremo. Lavoro, salario, pane, fuoco, coraggio, amore, tutto viene a mancargli nel medesimo istante. La luce del sole sembra spegnersi e allora, in quelle tenebre, tutti gli orrori sembrano possibili. L’anima brancola in cerca di aiuto, ma incontra solo l’obbrobrio e finisce per adattarvisi, vi aderisce perfettamente, deformandosi: salute, giovinezza, onore, verginità, pudore, l’ “epidermide” lucente dello spirito si sfalda e scopre invece la vergogna, il vizio e il delitto. Padri e madri, figli e sorelle, pezzenti e sovrani, tutti si aggregano a questa brumosa promiscuità che non ha né sesso né età. I Miserabili sono creature pallide e sventurate, alieni abitanti di un pianeta molto lontano da Sole e, pertanto, grigio e glaciale.

E’ proprio a questa schiera di spiriti incatenati alla solitudine di cui fa parte Jean Valjean. Anch’egli, fin dalla giovinezza, comprese di appartenere a quelle creature di Dio senza sostegno, senza guida, passanti alla ventura nella tetra marcia del genere umano. Uomo dalla forza e dalla agilità sovrumane, Jean Valjean parlava poco e non rideva mai, se non quei lunghi risi tipici del forzato, quasi un ghigno demoniaco; era portatore di uno sguardo attento, in cui si vedeva brillare perennemente una scintilla di disperazione, in apparenza sempre assorbito a contemplare qualcosa come se fosse una visione terribile.
Per colpa del furto di un misero tozzo di pane dettato dalla disperazione, Jean Valjean sarà costretto a passare 19 anni della sua vita in catene, come forzato, privato persino della consapevolezza di essere ancora un essere umano. In quel ventennio vissuto da recluso, leggi, pregiudizi, condanne, uomini, eventi, tutto andrà e verrà sopra di lui, camminandogli addosso, schiacciandolo con l’imponderabile peso della crudeltà e dell’indifferenza.

Quando lo incontriamo per la prima volta, Jean Valjean è appena uscito di prigione, e può essere assimilato a quelle anime sciagurate che già nella loro giovinezza hanno toccato il fondo di ogni sventura, protagoniste di una vita vissuta nell’assurdità e nella disumanità, condizioni che hanno finito per dotarle di uno stato d’animo indeterminato, capace di qualsiasi atto.
Sarà in questo punto cruciale della sua esistenza che Jean Valjean riceverà il perdono di un vescovo, il più grande assalto e l’attacco più formidabile a cui la sua anima poteva essere sottoposta. E’ così che il nostro protagonista dovrà fare i conti con una lotta colossale e decisiva contro se stesso, fra la propria malvagità e il gesto di estrema bontà di cui un altro uomo, in maniera totalmente disinteressata, gli ha fatto dono. A lui il verdetto: se non diventerà il migliore degli uomini, ne sarà il peggiore; se sceglierà la via della bontà allora sarà destinato a diventare un angelo, altrimenti la sua condanna sarà l’esistenza di un mostro.
Jean Valjean farà così la propria scelta e, da quel momento, il lettore verrà portato a seguire tutte le vicende che lo vedranno protagonista e che conseguiranno alla sua decisione. Come una massa formicolante di chimere danzati, nel corso della lettura, si distingueranno così, qua e là, ora vicini ora lontani ad altezze inaccessibili, tutti i personaggi del romanzo, alcuni fortemente illuminati, altri in penombra, ma tutti, indistintamente, Miserabili.

Fra questi, una delle prime anime che intreccerà il proprio cammino con quello di Jean Valjean sarà quella di Fantine. Fatine può essere descritta come una di quelle creature che possono sbocciare solo nel più profondo delle tenebre sociali, portanti su di esse il vessillo dell’anonimo e dell’ignoto.
Le uniche cose che possiede Fantine all’inizio del nostro racconto sono il suo nome, caduto su di lei come un goccia di poggia, la propria povertà e la propria civetteria, due consigliere fatali per una bella ragazza nel fiore della giovinezza. Fantine sarà ingannata e compiendo la scelta sbagliata si ritroverà sola e con una bambina da mantenere: il risultato di tutto questo sarà la sua rovina. La miseria peserà su Fantine, sulla sua grazia, sulla sua giovinezza, sulla sua maternità e tutto quello che la sorte potrà riservarle, le toccherà di sopportarlo; Fantine sarà costretta provare tutto sulla sua pelle, a soffrire tutto il possibile, a piangere tutte le lacrime e a perdere tutto ciò che poteva ancora avere un valore.

Ma non è solo al destino di una giovane e sventurata ragazza del popolo a cui quello di Jean Valjean sarà legato. Perché la condizione del Miserabile può incarnarsi anche in altri corpi, in figure di potere, come quella di Javert, ispettore di polizia ossessionato dal rispetto dell’autorità e dall’odio verso le ribellioni, due sentimenti relativamente buoni ma che egli rende malvagi a forza di esagerarli.
Oppure, per quanto singolare, la natura del Miserabile si può ravvisare anche nelle oscure anime dei coniugi Thénardier, appartenenti a quella classe bastarda di individui grossolani arrivati a una misera fortuna per grazia del destino, “creature nane” scaldate da una fiamma capace di renderle mostruose, che tendono al progresso solo per compiere il male.

Jean Valjean si troverà così a confrontarsi con diversi aspetti della cattiveria umana e della miseria della società. Si troverà a faccia a faccia con il destino della donna incarnato in Fantine e a quello della pubblica autorità riassunto nell’ispettore Javert. Soffrirà, patirà di nuovo, tornerà in carcere, questa volta solo per aver compiuto il bene, si abbevererà di nuove amarezze e sarà ancora ad un passo della perdizione. Ma, di nuovo, sarà l’amore a salvarlo, questa volta non quello di un uomo in odore di santità, ma quello di una bambina sventurata, Cosette, grazie alla quale Jean Valjean sceglierà, ancora una volta, di compiere il proprio cammino sulla strada della virtù.

La gioia suprema della vita sta nella consapevolezza di essere amati malgrado se stessi, soprattutto se si tratta di un amore fatto di virtù e di luce.
Jean Valjean non aveva mai amato nulla, non era mai stato né padre, né amante, né amico, per cui il suo cuore era pieno di amore vergine che non attendeva altro che una creatura su cui essere riversato. Quando Jean Valjean prende per la prima volta fra le braccia Cosette, è come se con le proprie mani toccasse la Provvidenza, incarnata nel corpicino malnutrito e tremante di una bambina, e tutta la passione e la dolcezza accumulata in lui improvvisamente si risvegliano, provocando in lui le fitte di una madre e lo strano palpito di un cuore che per la prima volta comincia veramente a battere.
Solo una mano di una bontà superiore avrebbe potuto mettere in contatto quell’ex forzato con quel sfortunata orfanella, solo un Dio avrebbe potuto far “legare l’agnello al lupo e far affezionare il lupo all’agnello”. La descrizione del rapporto fra Jean Valjean e Cosette sarà uno dei punti più sublimi e struggenti dell’intero romanzo, come solo due anime sventurate che finalmente si incontrano, colmandosi l’un l’altra, possono produrre. L’una completava l’altra: ciò di cui aveva bisogno Cosette era un padre, come Jean Valjean di un figlio, e il destino fece tutto il resto.

Molte sono ancora le figure che popolano la narrazione de ‘I Miserabili’, tutte profondamente caratterizzate e tutte indimenticabili, ognuna simbolo di una classe sociale, di un pensiero, di un’ideale, di un sentimento o di una tendenza spirituale. Ogni ragazza, ad esempio, difficilmente non riuscirà a non innamorarsi dell’impeto appassionato di Marcus, spirito ardente e rivoluzionario, emblema del potere della gioventù che vuole credere in un futuro migliore; oppure, solo un cuore di pietra riuscirà a non versare calde lacrime per la sorte della giovane e disperata Eponine, che si immolerà per amore e porterà così a compimento il proprio destino.

Come teatro di tutte queste vicende ci sarà sempre e solo Parigi, descritta dalla sue guglie più alte fino ai malmostosi abissi delle fognature; con grazia innata, la penna di Hugo sarà in grado di descrivere in maniera incredibilmente vivida e veritiera la Parigi rivoluzionaria delle barricate, la Parigi in guerra, con le piazze dominate dal tuonare dei tamburi della guarnigione in battaglia, la Parigi incrollabile, che vede sangue innocente versato sul proprio selciato, ma che non firma la propria resa. E, ancora, potremmo vedere il lato più bello e soave di questa città, quello delle passeggiate nel parco, del chiacchiericcio dei mercati o della tranquilla vita cittadina, per poi giungere al suo profilo più vergognoso e selvatico, che si materializzerà nelle periferie crepuscolari, nelle bettole all’angolo dei cimiteri, nei posteggi degli assassini notturni e nel misterioso fascino delle sue alte mura nere.

Nel 1850, prima dell’uscita dell’opera di Hugo, la parola “miserabile”, nel linguaggio di tutti i giorni, era legato al concetto di criminale, di emarginato, di reietto, di colui che presto o tardi sarebbe finito per subire un’esemplare punizione da parte dell’istituzione giudiziaria. Il fatto che dopo il successo editoriale del romanzo, la parola “miserabile” venne legata tutt’altro significato, ovvero a “essere degno di compassione”, fa capire quale sia stata la gigantesca portata rivoluzionaria di questo capolavoro.
Come affermò lo stesso Victor Hugo, ‘I Miserabili’ è uno specchio, nel quale tutti noi siamo chiamati a scrutarci. Gli specchi sono dicitori di verità, e per questo spesso odiati, ma sono l’unico strumento che permette a tutti noi di guardarci negli occhi.
‘I Miserabili’ è anche un’opera scritta per tutti i popoli, in quanto i problemi sociali, le piaghe del genere umano e le sue sofferenze non hanno confini o limiti, ma superano le frontiere, le terre, i fiumi, i deserti e perfino gli oceani. Anche oggi, nelle ore buie che, ahimè, tutti noi siamo ancora costretti a vivere, il Miserabile più che mai si chiama Uomo, e soffre sotto tutti i climi, e geme in tutte le lingue. Per accorgercene, basta aprire un po’di più gli occhi e guardarci intorno, ma soprattutto ricordare che nessuno è più Miserabile di chi decide di vivere senza amore.
Credits:
• IMAGE 4: ‘Hearts full of Love’ by Annie Leibovitz©
• IMAGE 10: ‘Tragic Muse’ by Annie Leibovitz©
• IMAGE 12: ‘Masters of the House’ by Annie Leibovitz©
• IMAGE 13: ‘The Runaways’ by Annie Leibovitz©
guarda qui ;)
http://simonascarioni.wordpress.com/2013/01/27/awards-p/
L’ha ribloggato su l'eta' della innocenza.
Hii great reading your blog